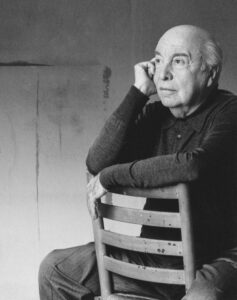Home / Esposizioni / Astratta anni ’50
Astratta anni '50
Afro, Dorazio, Sanfilippo, Scialoja, Tancredi, Vedova
19.12.2020 — 31.03.2021
Astratta anni '50
19.12.2020 - 31.03.2021Presentazione
Nell’ambito di un’attività espositiva che da oltre cinquant’anni promuove e approfondisce aspetti inediti o poco noti dei protagonisti dell’arte italiana del XX secolo, Galleria dello Scudo presenta dal prossimo 19 dicembre un’indagine circoscritta a un decennio senz’altro cruciale della pittura astratta in Italia nel secondo dopoguerra – gli anni ’50 – quando maturano esperienze che, nel panorama internazionale, rivelano prerogative stilistiche del tutto peculiari, nate in un contesto di profondo e articolato impegno teorico e critico.
Lo sguardo si focalizza sull’opera di sei autori – Afro, Piero Dorazio, Antonio Sanfilippo, Toti Scialoja, Tancredi ed Emilio Vedova – ponendo in evidenza gli elementi che ne connotano il linguaggio in una fase ben circoscritta del loro percorso. Gli esiti delle loro ricerche furono, peraltro, oggetto di interesse da parte di artisti, critici e collezionisti europei e d’oltreoceano, che riconobbero in ognuno di essi tratti distintivi specifici. Il percorso è suddiviso per personalità, secondo una progressione cronologica.
Afro: la poetica dell’“astratto concreto”
Scrive Cesare Brandi a proposito del mutamento operato da Afro nella sua pittura all’inizio degli anni ’50: “Afro, in questo improvviso sconvolgimento dei suoi motivi pittorici aveva individuato il suo nuovo principio formale, che non è il colore veneto e neppure il dinamismo espressionista della pennellata… Afro capovolge la posizione del quadro, da fondale a schermo: resa di colpo trasparente, la tela è come se la luce ne uscisse con quei raggi che il sole emette dalle nuvole al tramonto”. Le tele di questo periodo presentano un nuovo temperamento pittorico. Il colore è steso sulla tela in modo sempre meno impositivo, fino a divenire quasi diafano nei dipinti della metà del decennio; la sua trasparenza lascia filtrare la luce che, anziché provenire dall’esterno, muove da una ignota fonte endogena. Sono creazioni complesse, imperniate sull’uso di gamme cromatiche che dialogano, non sempre esplicitamente, con un segno grafico relativamente autonomo, ricche di passaggi diversi, sospese fra la dichiarazione di un referente immaginativo, reale o di fantasia, e il nascondere le loro origini.
I tre lavori ora in mostra attestano l’apprezzamento rivolto all’artista dal collezionismo statunitense. Giardino d’infanzia del 1951, esposto nel 1952 da Catherine Viviano, entra ben presto nella collezione di Lee A. Ault, collezionista d’arte e imprenditore nel settore dell’editoria, titolare della casa editrice Quadrangle Press, che curò la pubblicazione di monografie dedicate a Rufino Tamayo, Joan Mirò, o alle fiabe di La Fontaine illustrate da Alexander Calder. La piccola tela per L’ottomana I del 1952 fu venduta da Irene Brin e Gasparo del Corso, titolari della Galleria dell’Obelisco, ai coniugi Samuel J. e Audrey Levin, a cui si deve la donazione di opere di maestri internazionali del XX secolo al Saint Louis Art Museum. Doppia figura del 1954 venne acquistato nel 1955 da Stanley J. Seeger Jr., figlio di un magnate del petrolio di Dallas e lui stesso alla guida di un impero imprenditoriale. Seeger Jr. conservò a lungo il dipinto nella propria raccolta personale.
Emilio Vedova: Immagine del tempo e Dal Diario del Brasile, 1951-1954
Nei primi anni ’50 Emilio Vedova imprime al suo linguaggio un profondo cambiamento, quello che, dopo quattro anni di “geometrie nere”, lo porta a concepire nuovi cicli di lavori nati da suggestioni riportate in occasione di viaggi all’estero, incontri ed esperienze.
Il ricorso a composizioni monocrome, dominate da forti e dinamici intrecci, accomuna la serie di dipinti che l’artista presenta col titolo Immagine del tempo, nel suo esordio alla prima edizione della Biennale di San Paolo del Brasile nel 1951. I quadri di questo inizio di decennio appaiono anche in altri appuntamenti espositivi; è il caso del dipinto ora esposto a Verona, esposto per la prima volta in pubblico in occasione della mostra Peintres d’aujourd’hui, France-Italie / Pittori d’oggi, Francia-Italia al Palazzo Belle Arti al Parco del Valentino a Torino in quello stesso 1951.
La ricerca di una nuova profondità spaziale maturerà di lì a poco, come attesta la grande tela Dal diario del Brasile (Spazio inquieto) del 1954, tra i lavori inviati l’anno stesso alla XXVII Biennale di Venezia, dove fu acquistata dall’architetto Graziano Gasparini per la sua casa di Caracas.
Gasparini era stato commissario unico per il Venezuela nell’ambito della Biennale di Venezia; anzi, grazie al suo intervento il paese sudamericano fu il primo ad avere all’interno della Biennale un proprio padiglione permanente. Dopo la laurea alla Facoltà di Architettura di Venezia, dal 1945 al 1947 Gasparini aveva preso parte ai lavori di ristrutturazione dei padiglioni della Biennale, occupati durante il periodo bellico dalle truppe naziste. Nel 1948, a impresa ultimata, era partito per il Sudamerica, arrivando infine in Venezuela nei giorni del colpo di stato di Pérez Jiménez. Vi sarebbe rimasto tutta la vita, divenendo docente universitario e, dal 1974, direttore dell’istituto per il Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental del Consejo Nacional de la Cultura.
Dal diario del Brasile (Spazio inquieto) è un’opera centrale nella pittura di Vedova del decennio. Scelta dall’autore a illustrare un suo scritto – Infinite altre porte – uscito sulla rivista “Arti visive” del novembre 1954, verrà inoltre riprodotta da Piero Dorazio nel saggio sulla pittura italiana del secondo dopoguerra nel volume The World of Abstract Art, edito nel 1957 da George Wittenborn di New York, in cui dedica all’amico Vedova alcune interessanti considerazioni: “Emilio Vedova creates images of surprising and vertiginous movement. His strong personality seized on the style of futurist dynamism as something readily adaptable; he altered it, and in-creased in volume, number, and directions those linee di forza that made objective forms burst out into pure rhythm and expressive color. His recent works, mainly in black and white, often introduce calligraphic elements. Vedova builds them directly on the surfaces, with horizontal or vertical lines, into sensations that are unexpected and explosive.”
Toti Scialoja: le “impronte” e il colore all-over
In alcuni dipinti eseguiti fra il settembre del 1957 e i primi mesi dell’anno seguente, come i tre del 1958 ora esposti – Agnus n. 1, Terzo Agnello e Bilancia – Toti Scialoja dà alla tecnica dello stampaggio la sua prima formulazione. La materia è densa e gremita, stesa in frequenti e affannose sovrapposizioni, talvolta incantata di sé e del proprio rigoglio cromatico.
È questo il momento in cui la pittura di Scialoja, oltre a evocare esperienze meno radicali legate all’espressionismo astratto statunitense, può svelare limitate tangenze con il clima informale europeo.
Da alcuni brani del suo Giornale di pittura, si possono trarre informazioni sulle modalità tecniche adottate dall’artista. Amava preparare la tela a terra. Prendeva un foglio di carta leggera, oleata, su cui la materia cromatica avrebbe aderito, senza lasciarsi assorbire. Questo foglio duttile e sottile lo accartocciava stretto, in fretta, come un fazzoletto. Steso di nuovo a terra, e lisciato dalle righe più grossolane, lo riempiva di pennellate rapide. Poi lo rovesciava sulla tela, premendo, battendo, gridando, una due tre cinque volte: fino all’esaurirsi del colore e al cedimento del supporto fragile.
Le “impronte”, create da Scialoja alla fine degli anni ‘50, sono dominate da superfici sature di colore, steso sino al margine della tela, in un all-over che azzera qualsiasi distinzione tra immagine e sfondo.
Il “segno” di Piero Dorazio e Antonio Sanfilippo
“Dorazio è uno dei rari artisti italiani che ha saputo svolgere con la sua pittura un percorso rettilineo, destinato a raggiungere la meta senza passare attraverso pericolose o equivoche vie traverse. Sin dalle sue prime opere aveva intravisto la possibilità di creare un suo micro-cosmo ben ordinato e omogeneo, dove l’atmosfera suscitata da un tessuto estremamente raffinato eppure tenace, gli permettesse di evidenziare le sue doti di meticoloso cultore della ‘linearità’”.
Sono le parole introduttive dell’articolo monografico di Gillo Dorfles uscito sulla rivista “Le Arti” nel giugno 1966, in cui viene riconosciuta a Piero Dorazio una fase informale nata da una fugace attrazione per alcuni aspetti dell’action painting, ben presto superata dalla decisa svolta verso una nuova forma di rigore e di precisione costruttiva. Sospetto di forma del 1958 è l’eloquente testimonianza di questo cambiamento, sia pur circoscritto a un breve ambito cronologico, che anticipa i Reticoli dei primi anni ’60 e la successiva stagione pronta ad aprirsi a un lessico accostabile a certa “post-painterly abstraction” statunitense. Le composizioni, in questi anni, sono affidate a quell’insieme di determinismo e casualità costituito dall’azione di chi dipinge ancora con un pennello intriso di colore, senza ricorrere a proiezioni fotografiche, collage materici, oggetti ritrovati, o elementi di origine industriale.
I dipinti di Piero Dorazio e Antonio Sanfilippo, esposti per l’occasione alla Galleria dello Scudo, sono eco della stagione in cui il loro lavoro giunge a una condizione di primo piano, in ambito italiano e internazionale. Pur confrontandosi con gli autori che con loro hanno animato l’avanguardia romana dell’immediato secondo dopoguerra, hanno ormai assunto una presenza di tutto rispetto attraverso l’originalità delle loro opere, portandole a essere parte di quella “generazione eroica” che ha riformato l’arte della seconda metà del ‘900 partendo da istanze e spinte individuali e non da proclami e manifesti.
“L’opera di Sanfilippo va […] inquadrata in un vasto movimento pittorico internazionale, nel quale egli rimane uno dei protagonisti con un linguaggio e una tecnica personali e ben caratteristici. Sanfilippo non è un pittore propriamente ‘calligrafico’ di ideogrammi come Capogrossi, né cade nel gusto espressionista, come Vedova, né è un ‘action painter’ come Pollock. Egli ha una mano leggerissima e lavora di punta come un ‘fiorettista’, e mai perde di vista il fine ultimo dell’arte pittorica che non è l’estetica ma la poesia.”
Il profilo che Dorazio traccia di Sanfilippo e della sua opera nel 1992, a poco più di un decennio dalla sua scomparsa, delinea in termini puntuali la cifra identificativa che accomuna il loro linguaggio pittorico negli anni ’50. In questa fase sia in Sanfilippo che in Dorazio è il “segno” a costruire l’immagine: nel primo, il “segno”, nitidamente delineato, costruisce l’immagine attorno a una sorta di groviglio centrale, a un nucleo di energia centripeta rispetto al quale i margini della pagina pittorica sono istituiti come fondo; nel secondo il tratto pittorico, franto e disperso, satura l’intero campo della tela, sottoponendola a una tensione in ogni suo punto analoga.
Tancredi: 1959
Di Tancredi vengono esposte due tecniche miste su carta, eseguite entrambe nel 1959, un anno senz’altro cruciale per l’artista. Negli scritti, pubblicati per la prima volta nel catalogo dell’antologica, a cura di Marisa Dalai Emiliani, allestita alla Galleria Comunale d’Arte Moderna a Bologna nel 1992, si sottolinea lo spirito di ansia con il quale Tancredi affronta l’analisi e la rielaborazione delle intense esperienze vissute a Parigi a partire dall’inverno del 1959. Il bisogno di affermare un senso di continuità con la produzione precedente attesta, infatti, la portata delle novità formali e poetiche di quell’anno, destabilizzanti ma anche estremamente stimolanti.
I dipinti, ora esposti a Verona, sono riconducibili a una fase immediatamente successiva all’estate del 1959 trascorsa in Svezia e in Norvegia con la moglie Tove Dietrichson, durante la quale Tancredi porta a termine i dipinti poi inviati all’VIII Quadriennale Nazionale d’Arte a Roma, rassegna che, con oltre duemila lavori, offriva un’ampia panoramica sulla situazione artistica italiana nel quadriennio 1955-1959.
Nell’avanzata primavera del 1959, dunque, Tancredi decide di lasciare Venezia. Si ferma a Milano per svendere tutto quanto fosse sopravvissuto al febbrile lavoro degli anni precedenti. In estate si spinge fino a Oslo e Stoccolma, per raggiungere poi Parigi, dove nasce in dicembre la sua prima bambina, Elisabetta.
Seguono mesi di difficoltà esistenziali, ma anche di esperienze intense che agiscono come stimoli culturali di rinnovamento: contatti con Jean-Jacques Lebel e altri protagonisti vecchi e nuovi delle ricerche ispirate al Surrealismo, l’incontro con Giacometti, il confronto con un contesto dominato dalle azioni di Dubuffet e Klein, in una città profondamente segnata dalla guerra d’Algeria. All’inizio del 1960, ancora a Parigi, aderisce al movimento dell’Anti-Procès promosso da Alain Jouffroy e Jean-Jacques Lebel, e lavora alle grandi Facezie che definisce “scherzi accorati… fatti con un po’ di leggerezza e un tantino di amarezza”. Le opere che esporrà, di lì a poco, nella personale alla Galleria dell’Ariete nel 1961 saranno motivo di disorientamento per il pubblico, ancora ignaro di quanto il suo esempio possa in futuro influire su un’intera generazione di giovani artisti.